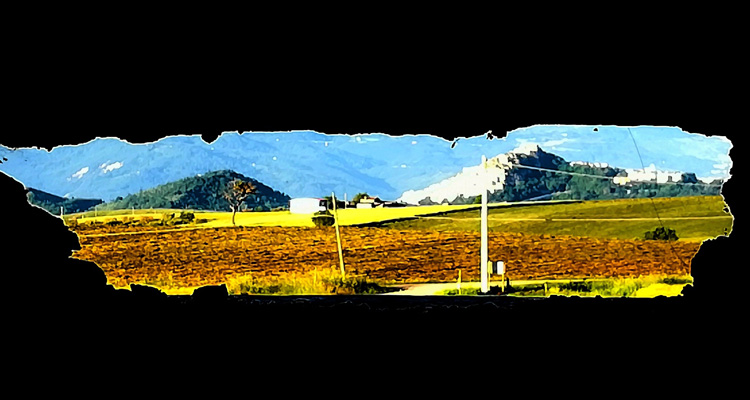Questione meridionale o pensiero meridiano?
Interrogativi e riflessioni intorno al viaggio nelle “terre dell’osso” (maggio – giugno 2018)
di Michele Nardelli
(foto di Mauro Arnese)
Nel corso del viaggio nelle “terre dell’osso”[1] si è fatta largo nei miei (nostri) pensieri una domanda che è divenuta ancor più assillante dopo essere ritornati nelle asprezze di un profondo nord dove la natura non si può certo dire sia meno ostile rispetto a quella che abbiamo attraversato nel nostro itinerario fra Sannio, Irpinia e Lucania.
La domanda è la seguente: esiste (ed è mai esistita) una questione meridionale?
So bene quanto questo interrogativo possa essere insidioso, dopo che alcune delle menti più fervide del Novecento, da Gaetano Salvemini ad Antonio Gramsci, hanno fatto di tale “quistione” uno dei temi cruciali del loro agire politico.
Ma è proprio il cambio di sguardo che si propone questo nostro “Viaggio nella solitudine della politica”, nel suo interrogarsi sui fondamentali, ad indurci domande cruciali che investono il presente, ovvero l’esito di quei paradigmi che hanno segnato il Novecento e con i quali ancora non abbiamo fatto i conti.
Osservata un secolo dopo e con occhi non condizionati dallo schema interpretativo del materialismo storico, la questione meridionale appare come parte di quel processo invasivo (culturale oltre che materiale) che ha dato del Mezzogiorno un’immagine artefatta di arretratezza, laddove i parametri sui quali misurare il progresso erano rappresentati da una modernità che – a partire dall’unità d’Italia e dalla rivoluzione industriale – ha prodotto un progressivo depauperamento di regioni ricche di natura e di storia, di cultura e di sapere.
In questo nostro immergerci nelle aree interne del Mezzogiorno abbiamo avvertito oltremodo la vicinanza con il “pensiero meridiano”, eresia che ha attraversato il Novecento accomunando nella critica alla vulgata economicistica dominante figure come Walter Benjamin, Albert Camus, Hannah Arendt, Pier Paolo Pasolini, Franco Cassano…
Non si tratta solo di un Mezzogiorno raccontato … dai Savoia. E’ qualcosa di ben più profondo che chiama in causa lo smarrimento della cultura del limite sulla quale ci ammoniva con straordinaria lucidità e chiaroveggenza il Leopardi del suo soggiorno napoletano, nel cogliere la frattura fra l’uomo e la natura proponendoci la metafora del “Fiore del deserto”[2].
Salvemini e Gramsci erano intellettuali espressione di queste terre. Ma – come scrive Franco Cassano – «il pensiero meridiano non muove della passione identitaria bensì da una riflessione sul lato d’ombra di ogni identità».
Rispetto al fondamentalismo dell’economia, il Mediterraneo è l’idea di uscire dall’etnocentrismo di stampo germanico, il mito del Reno nel regno dei Nibelunghi, della terra non contaminata dal mare e, come osservava Albert Camus, della “dismisura”. Quell’assenza di limite che è all’origine tanto del mito prometeico dell’uomo signore assoluto del mondo, come dei totalitarismi del Novecento che hanno sacrificato la natura e la bellezza in nome dell’azione e della potenza. Ne sono venuti Auschwitz, l’arcipelago Gulag, Hiroshima… la banalità del male.
Nessuno può chiamarsi fuori. «La storia della prima Internazionale in cui il socialismo tedesco lotta senza posa contro il pensiero libertario dei Francesi, degli Spagnoli, degli Italiani, è la storia delle lotte tra ideologia tedesca e spirito mediterraneo. Comune contro stato, società concreta contro società assolutista, libertà riflessiva contro tirannia razionale…»[3].
«Nulla ha corrotto la classe operaia tedesca – scrive Walter Benjamin – come l’opinione di nuotare con la corrente. Lo sviluppo tecnico era il filo della corrente con cui credeva di nuotare. Di qui c’era solo un passo all’illusione che il lavoro di fabbrica, trovandosi nella direzione del progresso tecnico, fosse già un’azione politica»[4].
Al contrario, il pensiero meridiano ci appare come la necessità di recuperare la lentezza a dispetto della velocità, la sobrietà rispetto all’ossessione della produzione e del consumo che ci ha portati sull’orlo dell’abisso di un’insostenibilità che ci ostiniamo a non vedere.
Analogamente, proviamo ad uscire – seppur con fatica – da una storia segnata dal materialismo storico e dal realismo politico che ha sacrificato l’umanesimo al machiavellismo, una separazione fra mezzi e fini che ha avuto come esito un’eterogenesi che ha trasformato il progresso in delirio, il sogno in terrore.
Avremmo dovuto comprenderlo, interrogandoci per tempo sulle radici di questa deriva. In realtà, in assenza di una rigorosa elaborazione collettiva del Novecento, il passato incombe. Così si continua a leggere il presente con le stesse chiavi di lettura di un secolo fa, sulla base di indicatori come il PIL o l’andamento dei consumi che descrivono in maniera distorta la realtà, seguendo parametri nazionali quando i processi economici (e non solo) sono almeno sovranazionali. Allo stesso modo, il Mezzogiorno sarebbe fattore di sottosviluppo, categoria quest’ultima fuori dal tempo perché sviluppo e sottosviluppo nella globalizzazione e nella finanziarizzazione dell’economia non esistono più[5].
Nel fondamentalismo economico novecentesco le risorse della natura, la storia e le opere d’arte che la raccontano, le tradizioni e i saperi che si materializzano nei mestieri, l’agire umano nel suo interloquire con il territorio, non sono contabilizzati. L’esito è che si è poveri nella ricchezza.
Rileggo d’un fiato “La questione meridionale” di Antonio Gramsci, nell’edizione degli Editori Riuniti del 1974 curata da Franco De Felice e Valentino Parlato. E’ invecchiata nella mia biblioteca tanto che vi ritrovo la ricevuta di un soggiorno di quarant’anni fa a Ribcev Laz, paesino nei pressi del Lago di Bohinj, in Slovenia, che visitai quando ancora c’era la Jugoslavia di Tito. Insieme a due biglietti della Slap Savica, la cascata che dà origine alla Sava che continua, malgrado le carte geografiche non siano più le stesse, a gettarsi nel grande Danubio nel cuore di Belgrado.
È come ritornare sui propri passi. Quegli scritti, che un tempo mi erano parsi illuminanti, oggi mi fanno capire quanto fosse stato fuorviante lo schema interpretativo che cent’anni fa il giovane marxista utilizzava nel leggere un Meridione che avrebbe potuto uscire dal sottosviluppo solo grazie all’industrializzazione dell’agricoltura e all’alleanza fra il moderno proletariato industriale del nord e le masse contadine del sud, proletarizzate dall’educazione collettiva ricevuta nelle trincee della prima guerra mondiale[6].
Nello storicismo dominante, il Risorgimento rappresentava la culla della nascita dei moderni stati nazionali e il superamento della “questione meridionale”, ovvero del sottosviluppo del Mezzogiorno, come condizione per superare quella che Gramsci definisce “disgregazione sociale”, l’estraneità delle masse meridionali rispetto allo stato unitario.
«Il contadino – scrive Gramsci – è vissuto sempre fuori dal dominio della legge, senza personalità giuridica, senza individualità morale: è rimasto un elemento anarchico, l’atomo indipendente di un tumulto caotico, infrenato solo dalla paura del carabiniere e del diavolo»[7]. Il proletariato dunque come classe nazionale il cui compito era imporre il problema dello Stato anche alle parti più arretrate della popolazione lavoratrice.
Lo stato contro la comunità, il modello industriale contro il lavoro artigiano e l’agricoltura, la dismisura contro la misura, il fuoco prometeico contro la cultura del limite.
Anche in queste latitudini lo scontro fra Marx e Proudhon, fra ideologia tedesca e spirito mediterraneo, ha lasciato il segno.
Errico Malatesta e Carlo Cafiero partirono dal Matese, oggi come allora al centro di tre regioni e con possibili vie di fuga in almeno cinque province diverse, nella loro impresa insurrezionale. Aree interne, ma non lontane da Napoli.
Per scelta e per caso anche noi siamo qui, dopo una visita a L’Aquila assurta a simbolo di un terremoto che ci accompagnerà in tutto il nostro itinerario, a rappresentare il richiamo della forza della natura verso il delirio dell’homo faber.
Partiamo anche noi dal Matese, senza velleità rivoluzionarie, con il solo desiderio di capire e senza ancora aver messo a fuoco che il tratto di questo viaggio risulterà, almeno ai miei occhi, proprio quello inerente la domanda iniziale di questo scritto: esiste (ed è ma esistita) una questione meridionale?
La vicenda della Repubblica del Matese non è solo il richiamo ad una pagina romantica della storia di questa terra. Malgrado un paesaggio che potrebbe farci sembrare improbabile che proprio qui, in questi borghi antichi, centoquarant’anni fa gli internazionalisti abbiano tentato il colpo insurrezionale, ci riporta al cuore di una vicenda profondamente moderna e che avrebbe segnato tutto il secolo successivo e anche oltre.
«L’Europa non è mai stata altrimenti che in questa lotta fra meriggio e mezzanotte» scrive Albert Camus[8]. E proprio in queste terre alte incontriamo in nuce le grandi questioni che il Novecento ci ha consegnato irrisolte, il conflitto fra “magnifiche sorti” e senso della misura, fra lavoro e ambiente, fra centralismo statalista e federalismo, fra città e campagna.
Ma, a ben vedere, anche i nodi che hanno segnato con effetti devastanti la storia del movimento operaio, il significato dell’agire politico, il rapporto far intellettuali e società, il tema cruciale del potere.
È la voce narrante di Bruno Tomasiello che ci accompagna in questo racconto fra passato e presente, a spiegarci che gli internazionalisti, con la loro “propaganda del fatto”[9], nemmeno non si ponevano il problema di prendere il potere, semmai di indicare al popolo come si faceva[10]. Destinati a perdere, ma almeno a non diventare demoni.
Per uno sparuto gruppo di anarchici i Savoia mobilitarono dodicimila soldati. E l’insurrezione finì. Non le contraddizioni, non il blocco agrario che governava il Mezzogiorno. E così s’impose nel tempo l’idea che la questione meridionale potesse trovare soluzione in quel disegno unitario rappresentato dal processo di sviluppo capitalistico e dai suoi caratteri di “meccanica necessità” che ne presiedono il funzionamento. Questo era lo schema che Gramsci, andando oltre il più tradizionale meridionalismo di Salvemini e chiuso anch’egli nell’orizzonte dell’ideologia tedesca, aveva immaginato.
La storia andò in altro modo, ma non nei suoi presupposti economicistici, così che il Mezzogiorno è diventato per il secolo seguente un simbolo di arretratezza, bisognoso di quello sviluppo capitalistico che avrebbe unificato il paese. E mentre a sinistra si continuò a pensare che la questione meridionale rappresentasse il nodo strategico della rivoluzione italiana, ovvero «la sconfitta del blocco conservatore che trova sempre più la sua saldatura e la sua unità nello Stato»[11], altri coltivarono l’idea di uno sviluppo dualistico, di uno squilibrio al quale porre rimedio attraverso interventi straordinari calati dall’alto, politica che avrebbe avuto la sua dimensione simbolica nella “Cassa per il Mezzogiorno”. È la storia di un Meridione che ha introiettato a tal punto questo racconto da diventarne insieme vittima e carnefice, tanto da ritrovarsi ancora oggi alle prese con gli scheletri ingombranti di quella politica e dei suoi veleni.
Non siamo né a Gioia Tauro, né a Taranto. Ma anche in questo nostro itinerario nelle aree interne del Mezzogiorno, malgrado l’intelligenza di comunità che cercano strade diverse, i segni di quel modello verticale, centralistico ed invasivo sono evidenti, tanto nelle forme più tradizionali (si pensi agli impianti ENI nel Vulture o allo stabilimento Fiat/FCA di Melfi), quanto in quelle nuove (e non meno impattanti) delle pale eoliche che per centinaia di chilometri hanno invaso l’orizzonte dell’Irpinia orientale.
Così queste terre sono state spolpate. Nella ricchezza della loro terra, nello stravolgimento di modelli di sviluppo esogeni, nello spopolamento di antiche e nuove emigrazioni, nell’aggressività dell’economia criminale, ma anche di politiche calate dall’alto che hanno trovato tutela nel metodo mafioso e paternalistico, dirottando le risorse finanziarie dello Stato su investimenti tanto casuali quanto insostenibili, di inguardabili ricostruzioni post terremoto (e di borghi abbandonati senza che ve ne fosse la necessità).
Nel parlarne con gli amministratori più avveduti della Comunità montana del Titerno coinvolti nella Strategia nazionale per le Aree Interne – che su impulso di Fabrizio Barca pure aveva suscitato grandi aspettative – avvertiamo una certa delusione, in primo luogo per il carattere farraginoso delle procedure e poi per l’omologazione indotta da strategie “buone” per ogni territorio. Che peraltro non sembra produrre né critica verso un modello verticale, né ricerca di forme partecipative in grado di far leva sulle forze interne a ciascuna comunità. Conosciamo bene anche in altre latitudini cosa comporta la disponibilità di risorse finanziarie in assenza di fervore comunitario. Le idee non mancano, ci viene detto, ma responsabilità e autogoverno non si improvvisano, esattamente come non sono date una volta per tutte.
Anche Matera non sfugge a questo destino. Perché anche il divenire capitale europea della cultura 2019 rischia di rientrare nella logica delle grandi opere, in termini di banalizzazione e di invasività. I sassi non sono un presepe per ricchi, così come le opportunità dei finanziamenti europei non possono venir gestiti attraverso “programmi Frankenstein”.
Decine e decine di incontri ci parlano di una terra resistente, di comunità che cercano seppure con fatica le strade di uno “sviluppo meridiano” che mette a valore il patrimonio umano e materiale di queste terre provate, certo, ma non piegate.
Abbiamo cercato e sentito l’eco dei suoni antichi ma vivi che – come scrive Vinicio Capossela – induce a restare o a ritornare sui propri passi, per non darla vinta al demone del progresso. Richiede, qui come altrove, un cambio di paradigma. Il pensiero meridiano, quel tornare “a pensare da sé” tanto caro ad Hannah Arendt che accompagna la prassi con la riflessione e la contemplazione.
In questo viaggio non ho percepito una questione meridionale. Terre che in un mondo interdipendente richiedono autonomia, lentezza, misura. Non c’è in questo alcuna “saggezza povera”, c’è piuttosto uno sguardo lungo che richiede di «lasciare l’epoca e i suoi furori adolescenti»[13].
[Torna a inizio pagina]
[1]
Espressione usata da Manlio Rossi Doria per descrivere l’alta Irpinia. Manlio Rossi Doria, La terra dell’osso. Mephite, 2003. Anche in Vinicio Capossela, Il paese dei coppoloni. Feltrinelli, 2015
[2]
Giacomo Leopardi, La ginestra (o il fiore del deserto)
[3]
Albert Camus, L’uomo in rivolta. Bompiani, 1994. Pag.326
[4]
Walter Benjamin, Angelus Novus. Saggi e frammenti. Einaudi, 2014. Pag.81
[5]
Mauro Cereghini, Michele Nardelli, Darsi il tempo. EMI, 2008. Pag.37 e segg
[6]
«Il problema dell’unificazione di classe degli operai e dei contadini si presenta negli stessi termini: essa avverrà nella pratica dello stato socialista e si fonderà sulla nuova psicologia creata dalla vita comune in trincea». Antonio Gramsci, La questione Meridionale, ER, 1974. Pag.66.
[7]
Ivi, Pagg.64 e 65
[8]
Albert Camus, L’uomo in rivolta. Bompiani, 1994. Pag.327
[9]
«Innanzi tutto, non bisogna giudicare la banda dal punto di vista della possibilità della vittoria. Noi non pretendevamo di vincere, poiché sapevamo che alcune diecine di individui armati di fucili quasi inservibili non possono vincere delle battaglie contro dei reggimenti armati di Vetterly. Partigiani della propaganda, coi fatti noi volemmo far atto di propaganda; persuasi che la rivoluzione bisogna provocarla, noi facemmo atto di provocazione». Bruno Tomasiello, La banda del Matese, 1876 – 1878, Galzerano, 2009
[10]
«La suggestione del messaggio arrivò persino a toccare l’animo di qualcuno: «Una donna», riportò Eugenio Forni nella sua requisitoria al processo di Benevento, «cui scendeva assai seducente nel cuore la promessa di tutto quel ben di Dio, ansiosa di vederne affrettato il conseguimento, si caccia nel più folto del rimescolio presso l’oratore; e volta a lui, ad alta voce e con piglio imperioso, chiede in nome del popolo che la banda, prima di andarsene, provveda per la divisione delle terre. “Ma no! Ci manca pure il tempo di farlo — risponde l’oratore — dovete far da voi; la banda deve andare altrove: I fucili e le scuri ve li avimo dato, i cortelli li avite. Se volite facite, se no vi fottite”».
[12]
De Felice, Parlato, Introduzione a Antonio Gramsci, La questione meridionale. Editori Riuniti, 1974. Pag 46
[13]
Albert Camus, L’uomo in rivolta. Pag.335